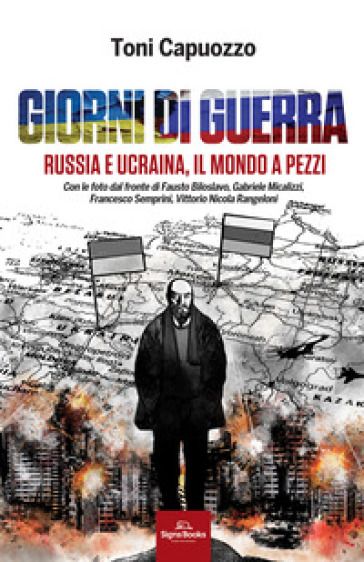
“Giorni di guerra. Russia e Ucraina, Il mondo a pezzi“. Intervista a Toni Capuozzo.
Ex Jugoslavia, Somalia, Medio Oriente e Unione Sovietica, luoghi e patimenti di popoli, di civili.
Dialogo, oggi, con Toni Capuozzo, giornalista e scrittore, ma prima di tutto un uomo che porta sul volto i segni di quanto ha visto, sentito, vissuto e di una professione condotta in prima linea, senza mai risparmiarsi ponendo, sempre, la deontologia al primo posto.
Chi è un inviato di guerra? Come ci si muove in questo campo?
Intanto parliamo di una specializzazione del giornalismo che è cambiata molto nel corso degli anni, perché c’è stata una crescita imperiosa delle nuove tecnologie.
Nell’arco della mia esperienza sono passato dal dettare i pezzi al telefono, all’uso del telefono satellitare che occupava, da solo, il bagagliaio della macchina, a telefonini normali che hanno campo anche a Kabul o Bagdad.
È una professione che è cambiata moltissimo nella strutturazione dell’informazione e dell’editoria in generale. Un tempo, l’inviato poteva fermarsi sul posto a lungo e occuparsi in profondità anche di guerre dimenticate.
Oggi l’informazione è molto più usa e getta, più nevrotica e, quindi, si hanno molte più notizie ricavate dallo schermo di un computer che dalla strada.
La cronaca delle ultime settimane ha riportato il ferimento di Corrado Zunino, giornalista di Repubblica e della morte del suo accompagnatore, nonché l’interprete ucraino Bagdan Bitik.
Chi sono queste figure di supporto? Quale rapporto si instaura con esse?
Genericamente questa figura viene chiamata fixer ed è colui che arrangia tutto, dalla logistica alle interviste, però va a confondersi intrecciarsi con altre figure, quelle dell’autista e, appunto, dell’interprete.
La loro funzione è decisiva per il lavoro di un inviato perché fanno da esca per situazioni locali: sono loro che, spesso, traducono le interviste, spiegano qualcosa che non sei arrivato a capire e consigliano sui luoghi da raggiungere.
Naturalmente, si va da giornalisti locali che necessitano di integrare il loro stipendio ma che lo fanno anche per passione, sono professionisti, ad altre persone che si improvvisano tali, soprattutto dove c’è un elevato numero di troupe di giornalisti stranieri e il mercato locale non è in grado di soddisfare tutta la domanda di fixer.
Nella mia esperienza ne ho provati di tutti i tipi, costruendo un solido rapporto umano.
Mentre tu racconti le sofferenze che sono lontane dal tuo Paese, loro ti accompagnano a raccontare le sofferenze del proprio Paese che, spesso, coinvolgono le stesse famiglie è, quindi, normale avere un sentimento di affettuosa preoccupazione.
Quando viaggi in macchina e ascolti notizie radio, loro pensano a casa e agli amici.
Sono vittime di un’ingiustizia, forse, inevitabile.
Se il giornalista ha, sempre, un biglietto di ritorno garantito, è coperto da assicurazione e, dunque, in genere, ha le spalle coperte, discorso diverso vale per i freelance.
Chi sta sul posto viene pagato cash, non esistono carte di credito o assegni o bonifici bancari, se succede qualcosa, una famiglia è destinata a rimanere scoperta: questo mi amara perché si costruiscono amicizie e affetti che restano però ineguali nelle condizioni.
Lei è stato testimone di molti scenari di guerra, quali sono gli episodi che la hanno segnata in negativo, ma anche, magari, in positivo.
È difficile distinguere, completamente, il positivo dal negativo, molte volte, anche le cose peggiori insegnano qualcosa.
Sicuramente l’assedio di Sarajevo mi ha segnato maggiormente: era la prima volta che raccontavo una guerra in Europa, una guerra che non mi aspettavo, una guerra difronte al quale l’indifferenza dell’Europa è durata molto a lungo.
Se penso alle armi che viaggiano adesso verso l’Ucraina non posso non ricordare che per quattro anni una città europea, inerme, è stata assediata e ridotta alla fame, con aiuti centellinati.
Ci sono anche altri ricordi che sono indelebili, il Medio Oriente, Gerusalemme, i territori occupati… sono storie che hanno accompagnato i miei primi impegni e gli ultimi e che resteranno, ancora per anni, a fare parte, ricorrente, delle cronache.
Sono storie senza fine.
Questo impedisce di archiviarle e considerarle storie chiuse che appartengono solo al passato.
Restano parte di te.
Quant’ è difficile raccontare una guerra?
In ogni campo, ogni giornalista, mantiene la sua cifra, il suo stile.
Per me resta un’impresa difficile, in cui puoi provare senza arroganza.
Devi provare a scrivere alcuni dettagli che aiutino a capire tutto, senza la pretesa che spieghino tutto.
Racconti una parte del fronte, non racconti l’altra parte.
Questo è molto importante perché, altrimenti, si scivola nel racconto della guerra buoni contro cattivi, in cui, inevitabilmente, i buoni sono quelli che conquisti e i cattivi sono gli altri, i disumanizzati.
Purtroppo, le guerre sono qualcosa che rendono tutti più cattivi e più buoni da una parte e dall’altra, nel senso che assisti ad episodi di generosità, ma anche di ferocia negli stessi schieramenti.
Bisogna sapere raccontare con umiltà e controllare la paura, questi sono elementi importanti.
Il resto è abilità tecnica: saper scrivere, saper girare un servizio, saperlo montare , avere buona salute, buone gambe e capacità di reggere la fatica e, molte volte, la fame.
Come riesce e come riusciva a gestire una narrazione e le emozioni ad essa legate?
Per quanto riguarda la paura, l’importante è provarla perché è una buona compagna di viaggio.
Serve tenere sempre presente che c’è un pericolo e a comportarsi di conseguenza.
Nel mio caso gestirla a lungo, almeno, nei conflitti che ho coperto in televisione è stato più semplice perché dovendo avere la responsabilità di una troupe, vale a dire un operatore che, qualche volta, vede a metà, perché ha l’occhio nel mio flynder e perciò ha limiti nel controllare la situazione.
Devi pensare alla sicurezza degli altri e questo ti fa essere doppiamente attento.
Sono fiero che i miei operatori, pur essendosi esposti insieme a me, non sia loro successo niente, poi ci vuole anche fortuna.
È necessaria la capacità di controllare la paura per evitare che si trasformi in panico e nello stesso tempo evitare la baldanza.
Si pensa sempre che a te non debba mai succedere niente, in realtà hai mille segnali che qualcosa non sta andando come dovrebbe.
Eliminare il rischio è impossibile, ma devi saperlo ridurre.
Recentemente ha pubblicato il suo ultimo libro “Giorni di Guerra. Russia e Ucraina, Il mondo a pezzi“ nel quale analizza quanto sta accadendo.
Qual è la reale situazione e come potrebbe evolversi?
È una situazione che racconto da lontano, non toccando il terreno, lo faccio sulla base di una lunga esperienza di conflitti.
In questo momento Washington, l’Europa e la Nato stanno puntando tutto sull’offensiva Ucraina.
A me pare che sia piuttosto difficile che l’offensiva Ucraina sia risolutiva, sicuramente costerà molto dal punto di vista di perdite di vite umane sia per gli ucraini che per i russi, ma difficilmente sarà una svolta decisiva nella guerra, non vedo le reali possibilità sul campo, questo significa che ci troviamo difronte a un’ostilità senza fine e che se non si costruiscono possibilità di via d’uscita negoziale rischia di divenire un conflitto permanente sempre sull’orlo del peggioramento, sempre sull’orlo di un allargamento, di un risvolto più drammatico.
Ecco, io credo che questa sia una situazione di stallo permanente e sanguinoso, ragion per cui occorre iniziare a pensare a una soluzione, quello che, in questo momento, l’Europa e la Nato non stanno facendo.
Entriamo, quindi, in altro tema da lei affrontato nel suo libro: l’importanza della diplomazia e della politica.
Si dice che la prima vittima di ogni guerra è la verità, ma la prima vittima è proprio la diplomazia.
La diplomazia è l’arte del dialogo e del confronto.
Devono esserci delle rinunce in nome del mantenimento della pace: è questo che è saltato.
In realtà, è saltato dal 2014 con questa guerra civile che ha sanguinato l’Ucraina orientale e che non è stata colta dalla diplomazia europea come qualcosa su cui intervenire ed è degenerata fino alla sciagurata aggressione Russa.
Insomma, è un fallimento della diplomazia da prima.
La diplomazia è anche la capacità di cogliere elementi di tensione che possono sfociare in conflitti quindi, essa deve essere preventiva e non successiva.
Passiamo al fotogiornalismo, quant’è fondamentale in queste come in altre circostanze e fino a che punto ci si può spingere nella divulgazione delle immagini.
Penso che conti molto la deontologia professionale.
In generale ho sempre pensato di essere dall’altra parte della telecamera e che non mi piacerebbe essere ripreso mentre sto mendicando un pezzo di pane, ho cercato, attimo per attimo, di avere questa morale dell’immagine, poi dipende molto quando le immagini sono trasmesse.
Trasmettere un servizio all’ora di cena e sapere che entri nella case in cui ci sono bambini e anziani, insomma.. certo, se vai in onda a una certa ora della notte è diverso.
Non si può scrivere un manuale però sono necessarie pietà nei confronti di corpi senza vita.
Si tratta di entrare in una realtà in punta di piedi senza rinunciare a raccontarla: questa miscela fa un buon utilizzo delle immagini.
Mesi fa c’è stato un appello per la liberazione del collega americano di origini russe Evan Gershkowich del Wall Strett Journal arrestato in Russia. Vuole dirci qualcosa?
La libertà di stampa è un bene prezioso e deve essere rispettato, ovunque, non mi riferisco solo ad Evan Gershkowich o a Julian Assange: è un valore universale.
Sappiamo bene che in alcuni Paesi essere giornalisti significa rischiare la vita ogni giorno, si pensi al Messico.
In Italia la condanna più grossa che pesa sul giornalista è la querela che si associa al doversi adattare al conformismo, sono quindi situazioni diverse.
La libertà di stampa è un bene a cui non dobbiamo rinunciare.
Mara Cozzoli





